Il mercato della musica negli ultimi decenni è cambiato molte volte, come conseguenza delle maggiori rivoluzioni tecnologiche, la principale delle quali ha riguardato l’archiviazione delle tracce musicali per il mercato privato. Questa storia ha origini molto lontane: tutto ebbe inizio dal fonografo di Thomas Edison, brevettato nel lontano 1878, che consisteva in un apparecchio in grado di registrare e riprodurre segnali audio tramite dei supporti di registrazione di forma cilindrica, detti cilindri fonografici. Tuttavia non ebbe fortuna.
Il concorrente del fonografo arrivò solo pochi anni dopo ed ottenne una maggiore fortuna: parliamo del grammofono, brevettato negli Stati Uniti da Emile Berliner nel 1887, conosciuto anche come giradischi (seppur a quest’ultimo si attribuisca nell’immaginario collettivo principalmente la registrazione e riproduzione di tracce musicali incise su dischi in vinile).
Il grammofono, infatti, a differenza del fonografo utilizzava dei dischi come supporto di registrazione e riproduzione delle tracce audio. Si tratta dei primi dischi, detti “a 78 giri” (ovvero i giri al minuto) – che, a differenza dei dischi in vinile – lanciati sul mercato nel 1948 dalla Columbia Records – in origine venivano prodotti in vetro o lamina di ferro coperti da uno strato di cera, ed in seguito in resina di gommalacca.
Anche il funzionamento dei dischi in vetro era lo stesso degli attuali dischi in vinile, o PVC, solo che questi ultimi grazie alle loro qualità fisiche hanno permesso una qualità del suono di gran lunga superiore, nonché un maggiore tempo di registrazione ed ovviamente una maggiore resistenza e durabilità nel tempo.
Per arrivare alla rivoluzione digitale bisogna attraversare il periodo delle audiocassette, la cui produzione di massa inizia nel 1965 ad Hannover, in Germania, per opera della Philips.
Ben presto diventano uno standard per le autoradio, mentre nel 1979 viene commercializzato il primo walkman, che, poco più grande di un’audiocassetta, permetteva di ascoltare la musica ovunque tramite cuffie.
Il funzionamento, anche in questo caso analogico, è simile a quello del vinile.
Le tracce audio registrate vengono incise su un nastro magnetico, che viene letto e riprodotto da un apparecchio elettronico – il riproduttore di cassette anche detto in gergo mangianastri o mangiacassette.
A differenza del giradischi, che riproduce il suono inciso sul vinile in modo fisico-meccanico, il riproduttore di cassette trasmette il segnale audio tramite componenti elettronici, in modo analogo alle radio.
LA RIVOLUZIONE DIGITALE
La vera rivoluzione della musica digitale ha inizio negli anni ’80 con la diffusione del Compact Disk – o CD – progettato e sviluppato da due multinazionali che già avevano fatto la storia nella riproduzione musicale in alta fedeltà: la Philips, che sviluppò e mise in commercio le audiocassette, e la Sony, che inventò e commercializzò il celebre Walkman.
Il CD è composto per il 90% da policarbonato, un materiale che fa parte delle molecole chimiche dette polimeri, e la memoria viene letta e scritta tramite dei fasci laser.
La digitalizzazione della musica, come nel caso di altri formati digitali, non è esattamente parallela alla storia del computer per usi ricreativi.
Nella digitalizzazione, tutti gli elementi che compongono la traccia e le opzioni di riproduzione – i diversi canali di trasmissione delle frequenze musicali ecc. – vengono immagazzinati in una memoria codificata, che in seguito viene letta e riprodotta tramite apparecchi in grado di estrarre tali informazioni dal supporto.
Con l’arrivo nelle case degli home computer, i formati digitali si sono adeguati agli standard dei vari sistemi operativi: Windows, Mac e Linux.
La memoria codificata contenente le informazioni della traccia audio si è trasformata, così, in uno dei tanti file leggibili dal nostro computer.
Inizialmente il computer non veniva visto come principale lettore delle tracce audio digitali.
Tuttavia, la comodità di ascoltare musica in alta fedeltà, tramite cuffie, e la presenza di internet in molte case ha creato subito una richiesta di tracce audio codificate al meglio per i computer di fascia non professionale.
Un’altra circostanza favorevole è stata la diffusione di piccoli lettori musicali digitali che, collegandosi al computer, possono ricevere le tracce musicali per poi riprodurle in qualsiasi luogo. Questi lettori musicali furono chiamati MP3, dal nome del loro “codec”, o sistema di codifica MP3 – ovvero un formato digitale molto diffuso, grazie alla sua eccellente qualità del suono e all’ottima capacità di compressione del segnale audio.
Il problema del mercato digitale, agli albori, era quello di subire la pirateria online, facilitata dal minor volume di memoria utilizzato dalle tracce musicali rispetto ai film.
Ciononostante, l’azienda Apple ha conquistato il mercato con il suo negozio online di musica digitale: iTunes Music Store.
Un’altra iniziativa del colosso americano fu il lancio del famoso lettore musicale iPod, tutt’ora commercializzato con il settimo modello, dotato di schermo touch. Infine, con il suo servizio cloud – iTunes – gli utenti della multinazionale di Steve Jobs avevano la possibilità di sincronizzare le loro tracce su più dispositivi dello stesso marchio.
Ma la grande rivoluzione si è avuta in tempi recenti, con le piattaforme di streaming digitale e le tecnologie smart.
Con l’avanzare generale della tecnologia, sono cambiate anche le richieste del pubblico: Il compromesso compressione/qualità, che rivoluzionò la musica digitale nel periodo precedente, è stato abbandonato a causa della richiesta di una qualità audio senza compromessi.
Da parte del produttore musicale, ciò significa aumentare la qualità di registrazione ai massimi livelli possibili – senza considerare se l’apparecchio che riprodurrà la musica sarà uno smartphone o un impianto high fidelity di fascia altissima.
Un esempio sono i formati di file musicali senza compressione alcuna, come il Waveform Audio File Format (abbreviato WAV o WAVE), oppure i formati che comprimono la traccia audio senza causare alcuna perdita nella qualità di riproduzione, come il Free Lossless Audio Codec (o FLAC).
Il principale difetto sta nel grandissimo spazio che questi formati occupano nella memoria di un dispositivo.
Tale difetto risultò comunque superabile abbonandosi ad una delle piattaforme di streaming musicale.
La più nota è Spotify, fondata nel lontano 2008, che conta al giorno d’oggi decine di milioni di utenti ogni mese e che dà la possibilità ai creatori di musica di pubblicare i loro brani sulla piattaforma, guadagnando parte degli introiti in base agli ascolti.
Si può dire quindi che non esistono più compromessi tra la richiesta e l’offerta musicale, anche quando questa riguarda riedizioni di vecchie tracce musicali, con qualità migliorata. Un chiaro esempio, quest’ultimo, di come la digitalizzazione della musica ha cambiato la cultura musicale non solo guardando il futuro, ma anche il passato.
Una lunga storia quella dei supporti musicali, che non ha smesso di stupire gli ascoltatori, senza contare che in tutto questo tempo il giradischi non è mai passato di moda e che c’è un ritorno importante alla richiesta e alla produzione di LP.

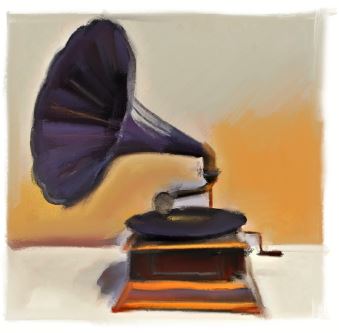
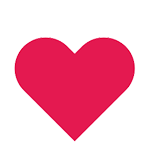

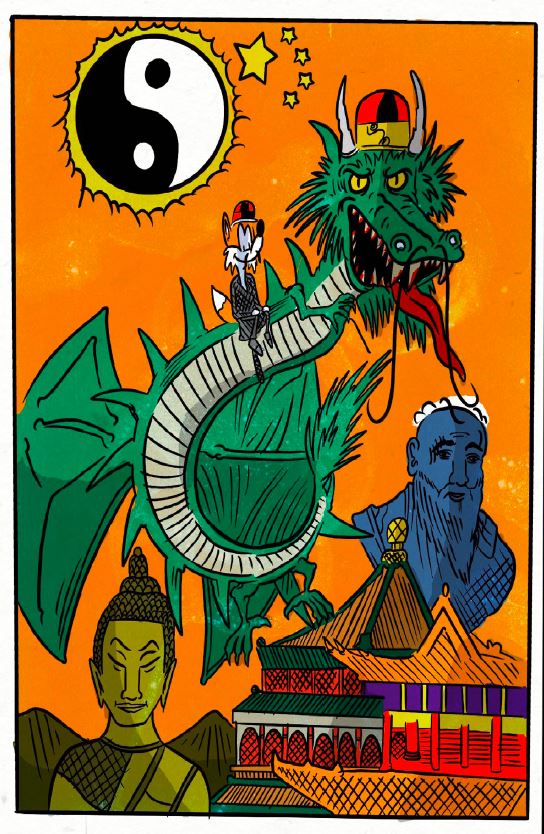
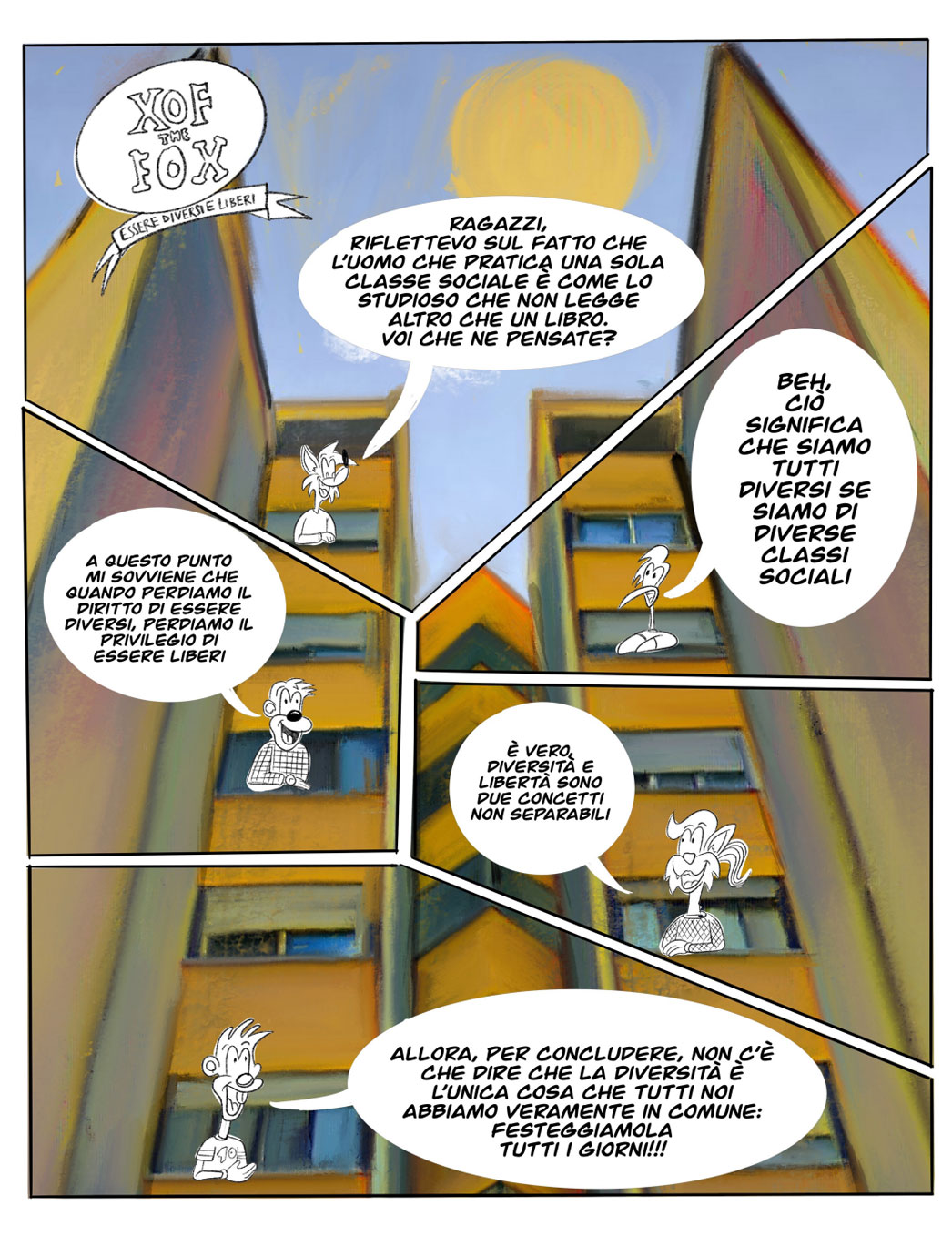
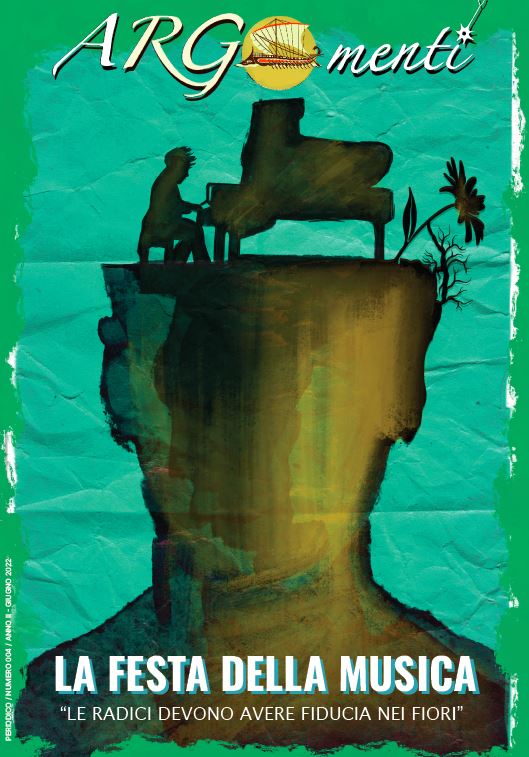

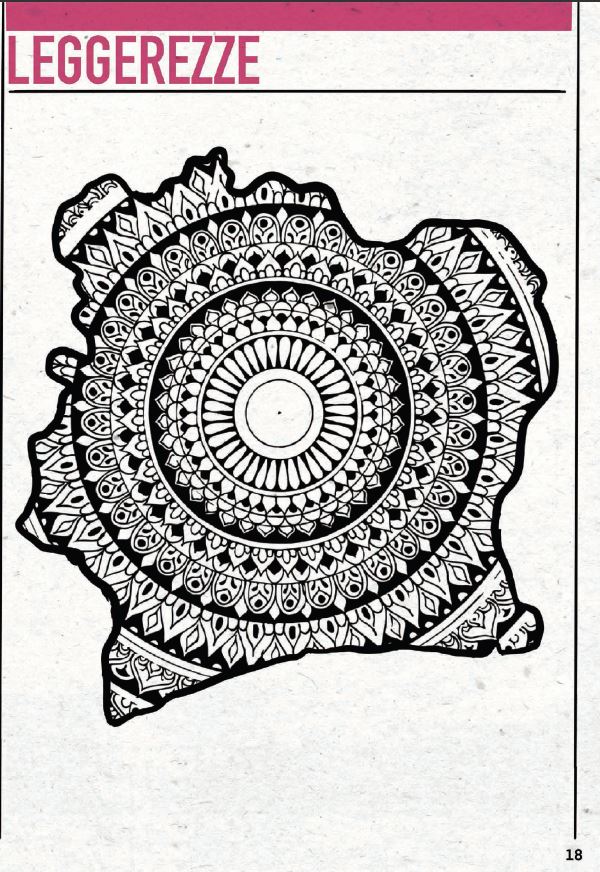

Lascia un commento