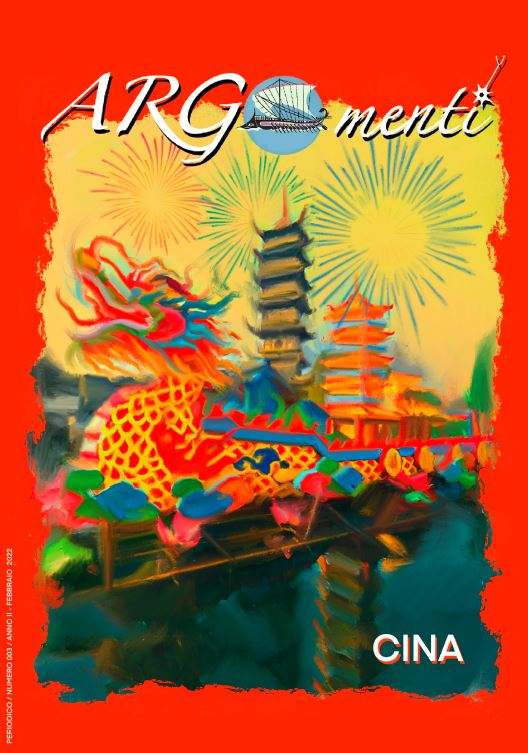“Spesse volte, se pedinato, sarei colto in qualche pizzeria di Torpignattara, della Borgata Alessandrina, di Torre Maura o di Pietralata, mentre su un foglio di carta annoto modi idiomatici, punte espressive o vivaci, lessici gergali presi di prima mano dalle bocche dei “parlanti” fatti parlare apposta”.
Così scrive Pier Paolo Pasolini nell’aprile del ’58 alla rivista Città Aperta in un articolo significativamente intitolato La mia periferia. Tra le opere del poeta, scrittore e regista proponiamo la lettura di una parte de Il pianto della scavatrice – poemetto che fa parte de Le ceneri di Gramsci. Il testo dipinge con le parole un momento di vita degli operai intenti al lavoro di preparare il terreno per la cementificazione, si ode lo stridore della scavatrice che urla e si percepisce il dolore, l’impegno e la speranza di ciò che muta anche per rendersi migliore.
Nella vampa abbandonata
del sole mattutino – che riarde,
ormai, radendo i cantieri, sugli infissi
riscaldati – disperate
vibrazioni raschiano il silenzio
che perdutamente sa di vecchio latte,
di piazzette vuote, d’innocenza.
Già almeno dalle sette, quel vibrare
cresce col sole. Povera presenza
d’una dozzina d’anziani operai,
con gli stracci e le canottiere arsi dal sudore,
le cui voci rare,
le cui lotte contro gli sparsi
blocchi di fango, le colate di terra,
sembrano in quel tremito disfarsi.
Ma tra gli scoppi testardi della
Benna, che cieca sembra, cieca,
sgretola, cieca afferra,
quasi non avesse meta,
un urlo improvviso, umano,
nasce, e a tratti si ripete
così pazzo di dolore, che, umano
subito non sembra più, e ridiventa
morto stridore. Poi piano
rinasce, nella luce violenta,
tra i palazzi accecati, nuovo, uguale,
urlo che solo chi è morente,
nell’ultimo istante, può gettare
in questo sole che crudele ancora splende
già addolcito da un po’ d’aria di mare…
A gridare è, straziata
da mesi e anni di mattutini
sudori – accompagnata
dal muto stuolo dei suoi scalpellini,
la vecchia scavatrice: ma, insieme, il fresco
sterro sconvolto, o, nel breve confine
dell’orizzonte novecentesco,
tutto il quartiere…È la città,
sprofondata in un chiarore di festa,
è il mondo. Piange ciò che ha
fine e ricomincia, Ciò che era
area erbosa, aperto spiazzo, e si fa
cortile, bianco come cera,
chiuso in un decoro ch’è rancore;
ciò che era quasi una vecchia fiera
di freschi intonachi sghembi al sole,
e si fa nuovo isolato, brulicante
in un ordine ch’è spento dolore.
Piange ciò che muta, anche
per farsi migliore. La luce
del futuro non cessa un solo istante
di ferirci: è qui, che brucia
in ogni nostro atto quotidiano,
angoscia anche nella fiducia
che ci dà vita, nell’impeto gobettiano
verso questi operai, che muti innalzano,
nel rione dell’altro fronte umano,
il loro rosso straccio di speranza.